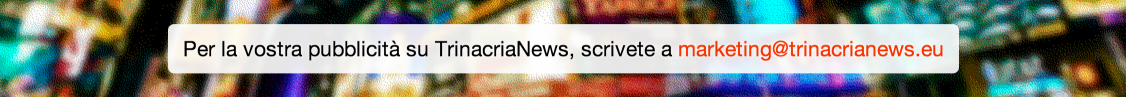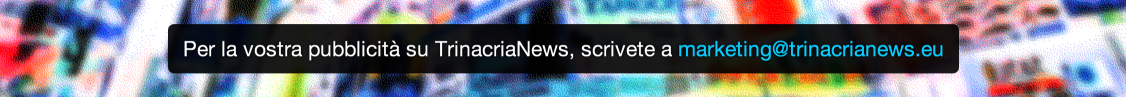La mia era una famiglia numerosa, di quelle di una volta, per intenderci di prima della guerra (o subito dopo): padre, madre e sette figli.
La mia era una famiglia numerosa, di quelle di una volta, per intenderci di prima della guerra (o subito dopo): padre, madre e sette figli.
Io ero il più piccolo, il settimo, e infatti mio padre, che di fantasia e d’immaginazione ci viveva (era un artista, nel senso letterale del termine, perché era maestro di violoncello, concertista e compositore) mi chiamò Benvenuto Settimo e, così facendo, a sentire lui, mi aveva reso un grande servigio (!). Non faceva che ripetermelo: “Tu parti avvantaggiato con un nome come questo! Anzi, con due nomi come questi!”. E ne era più che convinto. Invece, passai tutta la mia adolescenza a … nascondere il mio nome e quando mi chiedevano dettagli su quel “Benni” (come avevo detto a tutti di chiamarmi) io glissavo e solo davanti ad un’insistenza indeclinabile, mentivo spudoratamente. “Mi chiamo Benedetto”, oppure: “Mi chiamo Bernardo”. E, solo quando l’interlocutore mi sembrava inoffensivo, confessavo di chiamarmi Benvenuto. E la reazione era sempre la stessa: frizzi e lazzi e motteggi vari. Spesso insopportabili. La mia era una lotta quotidiana, incessante: allora c’erano le “bande”, i ragazzi vivevano per strada, i giochi ce l’inventavamo dal nulla: c’era “Acchiana u patri cu tutti i so figghi” e c’era “’A banniera”; c’era il giro d’Italia con i tappi delle bottigliette di gassosa e birra e c’era “’A strummula”, ovvero la trottola, che era un pezzetto di legno di forma ovale con un grosso chiodo sulla pancia: il chiodo la faceva girare, il chiodo azzannava la “carne” della “strummula” del perdente. Poi c’erano i giochi delle figurine, “’u susciuni”. Si soffiava su un mucchietto di figurine dei calciatori e quelle che si scoperchiavano erano il tuo bottino, la tua preda, la tua vincita.
In quegli anni così poveri di beni materiali come si poteva pretendere che non si ridesse nel sentire che mi chiamavo Benvenuto?
E io mi chiedevo inutilmente: ma benvenuto dove? E perché?
Gliene feci una colpa per almeno vent’anni, al mio grande padre, che, impassibile, davanti alle mie instancabili proteste, ripeteva: “Tu parti avvantaggiato…”, con quel che segue. Ma io, purtroppo, avvantaggiato non lo ero affatto, non lo ero mai, anche a prescindere dal mio strano nome: ero l’ultimo di una serie di fratelli in un’epoca di stenti e di difficile ripresa dopo la guerra. Già sopravvivere era arduo, pensa un po’ com’era spassarsela: ci voleva davvero molta fantasia e una straordinaria predisposizione all’ottimismo.
Ed io, da buon ultimo, dovevo aspettare che i miei fratelli si servissero prima di trovare sul piatto la mia porzione. Quando la trovavo.
Un ricordo che non mi ha mai lasciato, anche se sono passati decenni?
La fame!
Avevo sempre fame e non solo perché ero un ragazzo, che viveva per strada tra corse e rincorse di pallone, ma perché mi toccava l’ultima porzione, che era, inevitabilmente, la più striminzita. E guai a protestare, perché, altrimenti, non mi toccava neanche quella.
Mia madre (una mamma di quei tempi che da sola provvedeva all’intero menage della famiglia) faceva le umane e divine cose per compensare le “malefatte” dei miei fratelli, che poi malefatte non erano perché anche loro avevano fame e sfido chiunque abbia fame a guardare tanto per il sottile al momento della divisione delle parti. A tavola, lei mi faceva sedere accanto a sé e, siccome si alzava spesso per andare in cucina per preparare le altre pietanze, io ne approfittavo per svuotare il suo piatto, lasciato lì, apposta, alla mia mercè. Amore di mamma: per far mangiare me a sufficienza, lei digiunava!.
Mangiare anche della frutta, a pranzo e/o a cena era già una botta di fortuna, che spettava a pochi: alla mia numerosa famiglia capitava spesso perché mio padre era un musicista di valore, che andava in giro da concertista e guadagnava bene. Bene, relativamente, nel senso che non c’era concerto, pur profumatamente pagato, sufficiente a placare quell’orda di assetati e di affamati che erano i ragazzi d’allora e noi, i sette fratelli Caminiti, in particolare: noi sembravamo davvero insaziabili e mio padre non faceva che rinfacciarcelo! Orbene, al momento della frutta, momento che mio padre giustamente considerava il più importante del pranzo, come fosse un capriccio, se non addirittura un lusso (molto di più dell’attuale dessert) la divisione spettava categoricamente a lui: era lui che assegnava le più belle e grosse e mature pere o mele in ordine di … età dei figli e, quindi, a me, che ero u picciriddu ra casa toccava sempre la più piccola. Salvo quando mia madre rinunciava alla sua, ma accadeva di rado per esplicito divieto di mio padre. Tu così lo vizi!, le urlava e io, in quel momento, lo avrei incenerito, perché la frutta era (ed è ancora) per me un “vizio” irresistibile. Eppure, anche in quel clima di spartana severità, c’era chi trasgrediva, rischiando grosso: era mio fratello Vincenzo, l’altro artista di casa, violoncellista anche lui, allievo di cotanto padre. Ebbene, Vincenzo, alias “Enzo”, come lo chiamavano tutti, al momento della divisione della frutta, non sempre, ma spesso, giocava d’azzardo, si alzava, allungava una mano e si prendeva il pezzo migliore, sollevando l’ira funesta di mio padre: Come osi -lui parlava così, all’antica, un po’ all’Amedeo Nazzari di “Catene” o “I figli di nessuno” – prendere la più grossa? Ed Enzo, imperterrito: Perché, babbo, tu quale avresti preso? E il babbo: Di certo non la più grossa!
Tutto a posto, dunque: quella l’ho presa io!
E le risate generali seppellivano l’ultima bava di collera paterna. D’altronde, mio padre, da grande artista qual era, aveva spiccatissimo il senso dell’umorismo e, per il piacere che gli procurava una battuta salace, era capace di perdonare tutto e tutti.