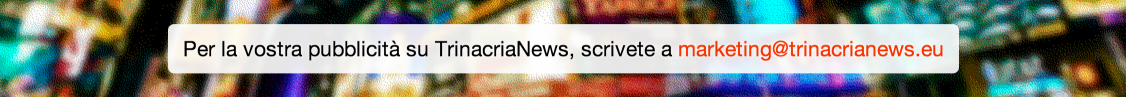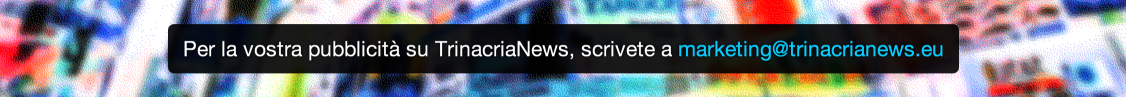Ho perso la mamma che avevo appena tredici anni .
Ho perso la mamma che avevo appena tredici anni .
Ultimo di sette figli, imparai presto a far tutto da solo, visto che i miei fratelli, tutti più grandi di me, si erano rapidamente dileguati e mio padre – che noi figli chiamavamo “Babbo” (il termine “papà” lui lo detestava perché, diceva, era un ridicolo “francesismo”) – era un valente concertista (primo violoncello al Teatro Massimo) e per molti mesi all’anno non si faceva vedere perché in giro con l’orchestra.
Imparai presto ad arrangiarmi: succede, quando ci si trova in stato di necessità, come nel mio caso. Un’infanzia difficile, dunque, eppure i ricordi che mi restano non li baratterei con quelli di nessuno, neanche dei figli di papà, cresciuti a panna e cioccolata , a colazione. Mio padre mi aveva affidato ad una cameriera (oggi si direbbe “colf”, o “badante”, ma a quei tempi questi termini non era neanche conosciuti) dallo sguardo bovino, buona come il pane, capace di resistere alle sfuriate del babbo, quelle rare volte che capitava in casa. Il babbo aveva una specie di mania della pulizia, anzi dell’igiene: era un fissato. Per lui niente era davvero pulito, c’era sempre qualcosa di sporco da eliminare: un’autentica tortura per la povera “Ciccina” – si chiamava così la cameriera, una donna sulla sessantina che veniva dal rione Ballarò e parlava un dialetto tutto suo, difficile da interpretare perfino per noi palermitani di casa – che, tuttavia, faceva “sì” con la testa, quando il babbo sbraitava, borbottando tra i denti : “Vabbè… Vabbè… Ora c’assistiemu… Un c’è probbrema!”. Il babbo non percepiva neppure il suono dei suoi lamenti, ma gli bastava quel suo chinar del capo, come gli dicesse: “Sì, sì, maestro, lei ha ragione, qui è tutto sporco!”: Quindi, si placava come d’incanto e, quasi a mo’ d’incoraggiamento, aggiungeva conciliante: “Lo vedi, Ciccina, che quando ti applichi le cose le capisci?… Avanti ricomincia a pulire!”.
E lei puliva, poverina, altro che, specialmente quando sapeva che il babbo sarebbe stato di … perlustrazione: si applicava al punto che, a fine giornata, era davvero stremata. Anche perché doveva tener testa anche a me, che non ero un tipetto tranquillo e gliene combinavo di tutti i colori: ma lei si era affezionata, mi trattava come fossi il suo quinto figlio, l’unico maschio, visto che aveva di suo quattro figlie femmine. Mi chiamava “’U cacanizzu”, parola a me del tutto sconosciuta, perché mai sentita prima, e che lei usava con un tono di voce così dolce e affettuoso che mi diventò subito cara: “ Un ti vestiri, cacanizzu, c’a mamà, ora ti fa ‘u bagnu!”.
E siccome a casa mia il bagno – intendo quello che oggi si definisce tale, cioè la vasca da bagno o la doccia – non c’era (come non c’era nella maggior parte delle case… normali; l’avevano solo i ricchi, cioè i negozianti del centro, i proprietari terrieri, i superfprofessioinisti, gli scienziati affermati: gli eletti della società d’allora, insomma), lei mi spogliava con le sue mani, nudo come un verme, e mi ficcava a forza in una sorta di pentolone, (che lei chiamava “u quararuni”) che serviva per la “lavata grossa” della settimana.
Una volta lì dentro, lei afferrava una specie di spazzolone e mi strofinava con la massima energia come fossi un puledrino, e non perché fosse diventata maniaca dell’igiene come mio padre, ma perché, dopo una settimana di giochi di strada, cui io mi dedicavo senza freni né limiti di sorta, per farmi tornare al mio colore naturale non c’era altro sistema che quello dello spazzolone da cavallo.
Mentre mi strofinava dalla testa ai piedi, ricordo che canticchiava certe filastrocche musicali del nostro folklore e, alla fine, guardandomi “tutta priata” negli occhi, invariabilmente mi chiedeva: “Comi ci vaiu?”. Altra sua frase misteriosa, che all’inizio non avevo decriptato ma, con l’andar del tempo, capii che voleva sapere se mi piaceva come cantava. E io, naturalmente, vista la mia precaria situazione del momento, le rispondevo con toni entusiastici: “ Bene, ci vai, Ciccina… Benissimo!”.
C’era un’altra sua espressione misteriosa, che ho udito proferire nella mia vita solo da lei, questa: “Un l’aiu pisatu!”, che era la sua risposta – sempre questa e mai nessun’altra – quando le si chiedeva: “Ciccina, ti pari giustu?”
Ciccina, era arrivata a casa mia durante la lunga agonia di mia madre, tre terribili mesi di sofferenze atroci: qualcuno doveva pur badare alle faccende domestiche, alle quali la mamma aveva provveduto sempre da sola.
Ricordo quando venne riportata in barella dagli ausiliari della clinica, dove era stata ricoverata nel tentativo di salvarle la vita con una seconda operazione. Quando la lettiga, sulla quale giaceva stremata, passò davanti a Ciccina, che le era corsa incontro, lei con un cenno della mano, le chiese di accostarsi alla sua bocca, e le sussurrò: “Ciccina, t’arraccumannu i rui picciriddi!”.
“I rui picciriddi” eravamo io e Riccardo, il penultimo della serie, quasi quattro anni più di me.
E Ciccina non venne mai meno alla sua promessa, anche se alle stentate parole della mamma non ebbe neanche il tempo di rispondere, ché i portantini se l’erano già portata via. Ma io li vedo ancora i lacrimoni che le scendevano sulle guance, con lei che tentava goffamente di asciugarsele con il palmo della mano.
Nell’indicibile disgrazia di perdere la mia mamma ch’ero solo un ragazzino, ebbi anche la fortuna di trovarne subito un’altra: buona, dolce e affettuosa come Ciccina, Si, un’altra, al di là della retorica e del finto pietismo: Ciccina mi aiutò a crescere come meglio non avrebbe potuto, trattandomi, lo ripeto, come quel figlio maschio che non aveva avuto. Le sarò sempre grato, perché se sono venuto su come un ragazzo normale, lo devo sicuramente alle sue attenzioni, alla sua dolcezza. Chissà che sarebbe stato di me se, dopo la morte di mia madre, solo in casa com’ero rimasto (visto che il babbo lo vedevo un giorno sì e dieci no, e quando lo vedevo, per me non era mai uno spasso) che strada avrei fatto, dove sarei andato a parare col mio carattere turbolento, la mia innata voglia di ribellarmi ad ogni prepotenza, ad ogni sopruso, ad ogni ingiustizia. Belle qualità sicuramente ma che vanno incanalate, inquadrate, incasellate e invece io in casa mi imbattevo, sia pure di tanto in tanto, nella drastica severità del babbo ed erano sempre scintille, fuochi e fiamme d’ambo le parti, con il solito finale: io in castigo, chiuso a chiave nella mia stanzetta, a piangere senza freni, invocando senza fine un solo nome. “Mamma, mamma, dove sei?”. Perché prima era lei che mi proteggeva, come faceva anche con gli altri fratelli, ma con me in particolare, un po’ perché ero “’u picciriddu ra casa” e molto perché io sapevo intenerirla con le mie lacrime strazianti, ché pareva mi stesse scoppiando il cuore: “Vieni, picciriddu ra mamma, vieni qui!” . E mi stringeva a sé e sento ancora il calore delle sue braccia, qualcosa di unico, che non ho mai più provato nella vita. Per niente e per nessuno.